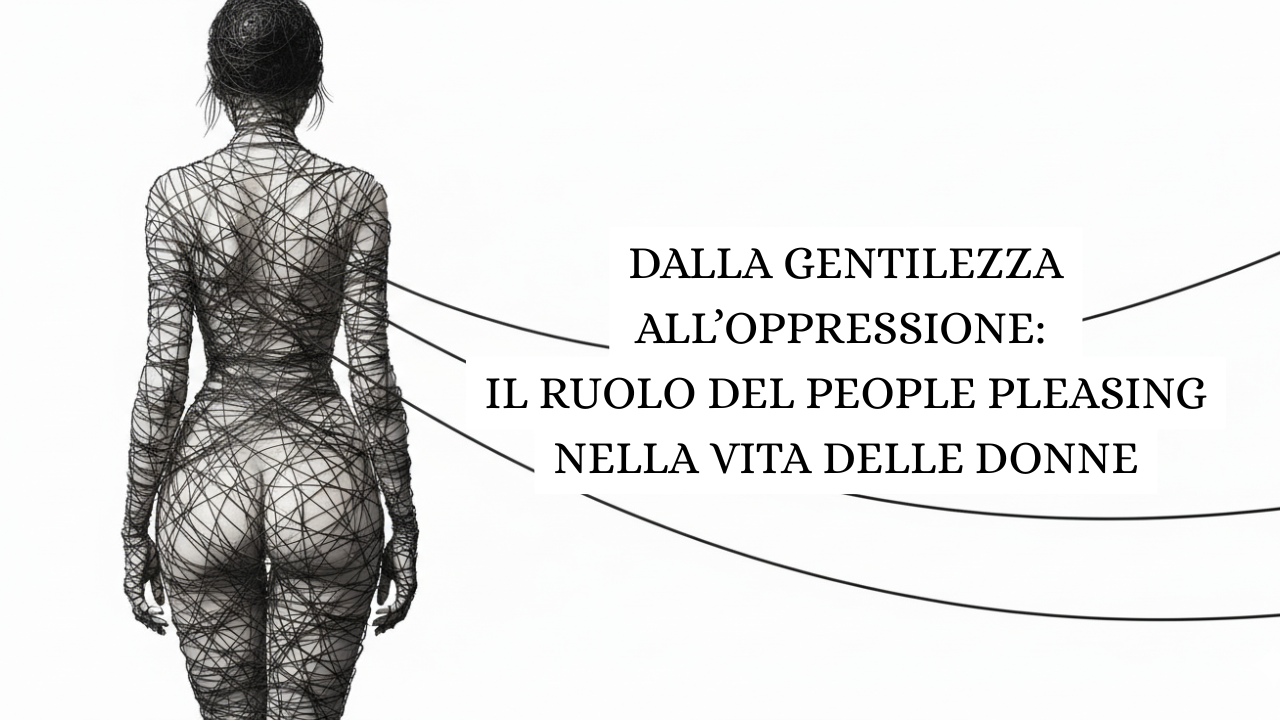
Dire sempre “sì”, essere disponibili, accomodanti, pronte a prendersi cura degli altri: sono qualità che nella nostra cultura vengono associate all’idea di gentilezza. Tale atteggiamento, quando esasperato, rischia però di diventare una guida costante delle nostre scelte, modellando le relazioni e guidando le priorità quotidiane così da trasformarsi lentamente in una gabbia invisibile.
Il people pleasing: la trappola del compiacere
Il people pleasing è un termine che in psicologia descrive la tendenza a compiacere gli altri anche a costo di sacrificare sé stessi, fenomeno complesso e diffuso, che affonda le sue radici sia in dinamiche individuali sia in pressioni sociali e culturali. Non si tratta semplicemente di essere gentili: è un modo di vivere e relazionarsi che porta a mettere sistematicamente le esigenze altrui davanti alle proprie, con conseguenze rilevanti sul benessere psicologico e relazionale.
Dal punto di vista psicologico, il people pleasing trova spesso origine nelle esperienze precoci e nei modelli di attaccamento. A partire dagli anni ’30, gli studi di John Bowlby hanno evidenziato come la qualità del legame tra madre e bambino influenzi profondamente lo sviluppo delle funzioni adattive primarie. Tale legame attiva un sistema comportamentale innato, orientato a mantenere la vicinanza con la figura di accudimento, percepita come “base sicura” capace di offrire protezione e rassicurazione. Negli anni la ricerca sull’attaccamento ha permesso di individuare i modelli che derivano da un attaccamento insicuro: situazioni in cui il bambino non sperimenta costanza, disponibilità o prevedibilità nella risposta del caregiver. In questi casi, invece di sviluppare fiducia e sicurezza, il bambino cresce con un senso di incertezza in quanto non sicuro che i propri bisogni emotivi verranno accolti, predisponendosi a schemi relazionali fragili in età adulta. Il minore che cresce in un contesto in cui sente di dover “guadagnare” amore e attenzione impara presto a mettere in atto un comportamento compiacente, convincendosi che la strada più sicura per mantenere la vicinanza dell’altro è quella di adattarsi, dire di sì ed evitare conflitti.
Questo schema, che nell’infanzia può servire come strategia di sopravvivenza emotiva, tende a cronicizzarsi e a diventare uno stile relazionale anche in età adulta. Il risultato è una personalità che fatica a dire no, che teme il rifiuto, si percepisce fragile o inadeguata e pur di mantenere l’approvazione altrui sacrifica i propri bisogni e desideri. Le conseguenze, spesso, sono deleterie portando a sintomi d’ansia, esaurimento, sintomi depressivi e relazioni superficiali, in cui la persona non si sente davvero vista per ciò che è, ma solo per ciò che offre.
Il confine sottile tra cura e oppressione
Se queste dinamiche possono riguardare chiunque, nelle donne assumono una connotazione particolare. Gli stereotipi di genere hanno a lungo descritto e prescritto il ruolo femminile come accogliente, arrendevole, comprensivo. La società tende a premiare la donna che si prende cura e si fa carico dei bisogni degli altri, spesso a scapito dei propri. Tale modello culturale si intreccia con l’educazione ricevuta fin dall’infanzia, quello che spesso definiamo come “la brava bambina” che non crea problemi ed è sempre di buon umore ma che con il tempo porta molte donne a interiorizzare l’idea che il loro valore sia legato alla capacità di rendersi utili e disponibili. Nel momento in cui invece la donna decide di uscire da questo schema, mostrando assertività o mettendo dei confini, spesso si trova a fare i conti con la disapprovazione sociale: viene percepita come “egoista”, “fredda” o addirittura “aggressiva”. Così, il people pleasing diventa non solo una scelta personale, ma anche una pressione sociale che mantiene le donne nel ruolo di caregiver primario, sia in famiglia che sul lavoro.
Il prezzo da pagare, tuttavia, è alto. Sul piano personale, il compiacere cronico porta a una progressiva perdita di autostima: se i propri bisogni vengono costantemente messi da parte, si finisce per dimenticare quali siano, per non riconoscerli più. Sul piano relazionale, il rischio è di costruire legami sbilanciati, in cui il dare e il ricevere non sono equilibrati e in cui il silenzio sulle proprie necessità genera frustrazione e invisibilità. Sul piano sociale, infine, il people pleasing contribuisce a perpetuare modelli oppressivi difficili da scardinare. Una società che continua a premiare la donna che si sacrifica e a criticare quella che si afferma resta una società in cui la libertà femminile è limitata.
Eppure, non bisogna confondere la gentilezza con la compiacenza. Prendersi cura degli altri è un valore fondamentale e la capacità di empatia e di attenzione è una risorsa preziosa nelle relazioni. Ciò a cui bisogna porre attenzione è quando questa attitudine diventa un obbligo, quando smette di essere una scelta consapevole e si trasforma in un automatismo, perde la sua autenticità e diventa oppressione. La vera differenza sta nel confine: una gentilezza che nasce dalla libertà è un dono, una gentilezza che nasce dalla paura è una catena.
Il momento di rompere le catene
Uscire dal ciclo del people pleasing non è semplice, ma è possibile. Il primo passo è la consapevolezza: imparare a riconoscere i propri schemi relazionali e a distinguere tra quando si agisce per vera generosità e quando lo si fa per paura di deludere. Da qui, diventa fondamentale esercitarsi nell’assertività, cioè nella capacità di dire no senza sensi di colpa, è infatti possibile esprimere i propri bisogni e i propri limiti senza il timore di perdere la relazione. Non si tratta di diventare egoisti ma di comprendere che prendersi cura di sé è la condizione necessaria per prendersi cura degli altri in modo sano. La psicoterapia può offrire strumenti preziosi in questo percorso, così come il sostegno di reti sociali e comunità che valorizzano modelli femminili diversi, liberi dall’obbligo di compiacere.
Conclusione
Il people pleasing, in fondo, racconta una storia antica: quella di donne educate a essere gentili fino a scomparire. Oggi, però, può raccontare anche una storia nuova: quella di chi sceglie di trasformare la gentilezza in un atto libero, non imposto, di chi riscopre che dire “no” non significa rifiutare l’altro, ma affermare sé stessa. Come ha scritto Audre Lorde, “prendersi cura di sé non è autoindulgenza, è auto-conservazione, ed è un atto politico.” In questa prospettiva, rompere il ciclo del compiacere non è solo un gesto personale, ma un passo collettivo verso una società in cui la gentilezza non sia più sinonimo di oppressione, ma di libertà.
Dott.ssa Chiara Affaitati
Bibliografia
Banse, R., Gawronski, B., Rebetez, C., Gutt, H., & Bruce Morton, J. (2010). The development of spontaneous gender stereotyping in childhood: Relations to stereotype knowledge and stereotype flexibility. Developmental Science, 13(2), 298-306.
Bowlby, J. (1989). Una base sicura: applicazioni cliniche della teoria dell'attaccamento. Cortina.
Ellemers, N. (2018). Gender stereotypes. Annual review of psychology, 69(1), 275-298.
Li, X. (2022). How Attachment Theory Can Explain People-Pleasing Behaviors. Exploratio Journal.
Kuang, X., Li, H., Luo, W., Zhu, J., & Ren, F. (2025). The mental health implications of people‐pleasing: Psychometric properties and latent profiles of the Chinese People‐Pleasing Questionnaire. PsyCh Journal.
Prentice, D. A., & Carranza, E. (2002). What women and men should be, shouldn't be, are allowed to be, and don't have to be: The contents of prescriptive gender stereotypes. Psychology of women quarterly, 26(4), 269-281.