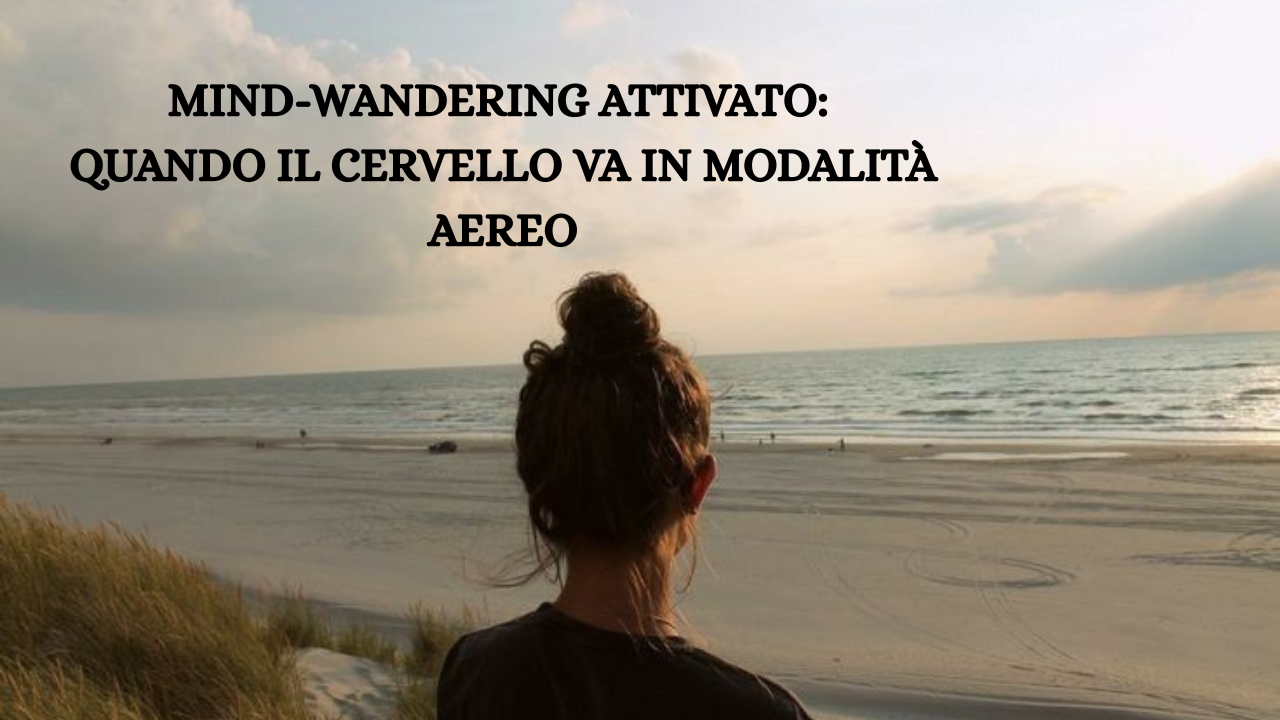
Ti è mai capitato di essere al lavoro, a scuola o anche solo in fila al supermercato e ritrovarti a pensare a tutt’altro? Progetti futuri, ricordi, conversazioni immaginarie… Questo è il mind-wandering, il vagabondaggio mentale. Per anni è stato considerato una semplice distrazione, qualcosa da correggere per tornare “sul pezzo". Oggi le neuroscienze ci raccontano una storia diversa: quando la mente vaga, il cervello non si spegne, anzi, entra in una delle sue fasi più complesse e interessanti.
Spesso consideriamo questi momenti come distrazioni o perdite di tempo, soprattutto in un mondo in cui siamo bombardati da notifiche, social media e impegni continui. Eppure, dal punto di vista psicologico e neuroscientifico, il Mind-Wandering rappresenta un’attività cognitiva fondamentale.
Grazie agli studi di neuroimaging, sappiamo che durante il mind-wandering si attiva la Default Mode Network (DMN), una rete di aree cerebrali che comprende la corteccia prefrontale mediale, il precuneo, la corteccia cingolata posteriore e altre strutture legate alla memoria autobiografica, e la corteccia cingolata posteriore, che integra informazioni interne. Questa rete entra in funzione quando non siamo concentrati su un compito esterno e ci permette di elaborare ricordi, simulare scenari futuri e dare un senso alle esperienze personali. In pratica, anche quando sembra che il cervello stia “dormendo”, è in realtà impegnato in processi complessi e funzionali. Ricerche recenti hanno fatto un passo in più: un gruppo dell’Università di Osaka ha mostrato che durante questi momenti l’ippocampo produce delle particolari onde cerebrali chiamate sharp-wave ripples, le stesse che sono cruciali per consolidare la memoria. In altre parole, quando sogniamo a occhi aperti, il nostro cervello sta facendo “manutenzione” dei ricordi e riorganizzando informazioni importanti.
Uno dei benefici principali del Mind-Wandering riguarda la creatività. Studi scientifici hanno dimostrato che lasciare libero il pensiero favorisce la connessione tra idee distanti, permettendo di trovare soluzioni nuove e originali a problemi complessi. Ma non è tutto: questi momenti spontanei e liberi aiutano anche a sviluppare autoconsapevolezza e a elaborare emozioni, favorendo la regolazione emotiva e la comprensione di sé.
Inoltre, il Mind-Wandering, come accennato precedentemente, ha un ruolo cruciale nel consolidamento della memoria. Mentre la mente vaga, la DMN elabora e integra esperienze che fanno parte del nostro passato, facilitando l’apprendimento e la pianificazione futura. È una sorta di manutenzione interna compiuta dallo stesso cervello, indispensabile per mantenere equilibrio cognitivo ed emotivo.
C’è però una distinzione importante da fare: il Mind-Wandering naturale è diverso dalla distrazione digitale. Scorrere continuamente i social o rispondere a notifiche impedisce alla DMN di attivarsi, frammentando l’attenzione e riducendo i benefici cognitivi ed emotivi dei momenti di pausa. Perché il cervello lavori davvero “in modalità aereo”, ha bisogno di silenzio, di spazi vuoti e di momenti in cui non siamo guidati da stimoli esterni costanti. Integrare il Mind-Wandering nella vita quotidiana non richiede grandi cambiamenti. Può bastare osservare il mondo mentre si passeggia, scrivere senza obiettivi precisi, dedicarsi ad attività manuali, leggere o semplicemente concedersi qualche minuto di pausa senza stimoli digitali. Questi momenti apparentemente vuoti sono in realtà fondamentali, momenti di reset che favoriscono la creatività, l’introspezione, il recupero mentale e la regolazione emotiva.
In un’epoca in cui tutto corre veloce e la mente è continuamente sollecitata, concedersi il lusso di vagare con i pensieri non è una perdita di tempo: è una strategia psicologica e neuroscientifica per prendersi cura di sé e del proprio cervello. Il Mind-Wandering ci ricorda che a volte, per far funzionare al meglio la mente, bisogna semplicemente lasciarla libera di volare e di perdersi in un “altrove” funzionale al nostro benessere.
Dott.ssa Giovanna Signore
Bibliografia
Iwata, T., Nishi, Y., Tamura, M., Saito, Y., & Takahashi, S. (2024). Hippocampal sharp-wave ripples correlate with periods of naturally occurring self-generated thoughts in humans. Nature Neuroscience.
Sorella, S., Crescentini, C., Matiz, A., Chang, C., & Grecucci, A. (2025). Resting-state BOLD temporal variability of the default mode network predicts spontaneous mind wandering and negatively correlates with mindfulness abilities. Frontiers in Human Neuroscience, 19, 1515902.
Kernbach, J. M., Yeo, B. T. T., & Margulies, D. S. (2024). The architecture of the human default mode network explored via cytoarchitecture and connectivity. Nature Neuroscience.
Menon, V. (2023). 20 years of the default mode network: A review and synthesis. Neuron, 111(14), 2249–2273.